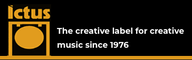L'INTERVISTA di Aldo Del Noce
Non manca certo il materiale di riferimento, attuale o mnemonico, per approcciare il mondo del vibrafonista autore ed esteta milanese, ed in particolare l’apprezzamento della sua discografia fluviale e fuori contabilità nonché l’eclettismo del suo approccio estetico ‘globale’ e dichiaratamente trans-mediale. Lo scrivente riprende dunque volentieri la conversazione con Sergio Armaroli, già affrontata con spirito di completezza in una precedente intervista, datante già tre anni orsono (all’alba della grande pandemia), ma evidentemente da aggiornare, non soltanto in considerazione delle nuove produzioni, tra cui una duplice rivisitazione (o de-costruzione) dei materiali di Thelonious Monk, e collaborazioni in ambito sia post-accademico che avant-jazz; oltre a sempre diversificate esternazioni concertistiche ed eterogenee iniziative, tra cui poniamo la focale su un suo inedito approccio al vibrafono in solo nel recente album Vibraphone solo in four part(s) (edito da Dodicilune), per il quale si abbozzavano definizioni introduttive tra cui “Euritmie del possibile” o “campi armonici cangianti”. Ineluttabile e per lo più incontenibile la ricchezza delle argomentazioni, a segnare un pensiero personale attraversato non solo dal naturale eclettismo ma anche da un entusiasmo contagioso, uno spirito partecipativo e grande lucidità.

Perché un album solo? Oltre alla dimensione di verità, si può anche considerare una dimensione confessionale?
Un album in solo nasce sempre da una necessità molto personale, intima e privatissima; soprattutto dopo una ricerca più che ventennale attraverso e con il vibrafono, lo strumento che mi ha accompagnato in tutti questi anni e che meritava un ‘focus speciale’, un punto d’arrivo o meglio: un approdo momentaneo. Così nell’aprile del 2022, dopo un lungo periodo di studio e di solitudine complice anche l’emergenza sanitaria che ho vissuto come occasione di introspezione e scoperta spirituale, mi sono ritagliato una giornata solo per me con il mio vibrafono e nient’altro, quasi in un voler “mettersi alla prova” – una prova di contatto e non di bravura s’intende, una prova di esistenza concreta e reale invece, partendo da una domanda fondamentale e la possibilità di essere con il mio solo suono presente a me stesso e al mio strumento. Dimenticando così tutto ciò che si è appreso nel tempo e semplicemente stando con il proprio strumento: in solitudine. Alla ricerca di una profondità e semplicità nel suonare, entrando in studio di registrazione, dimenticando ogni contingenza per relazionarsi con ogni singola nota, all’interno di una concezione, che è più un modo di vivere l’armonia in senso anarchico giorno dopo giorno. E ciò proprio con il vibrafono, che per sua natura tende a mimetizzarsi con altri strumenti e altri suoni in una ricerca sempre rinnovata di identità. E in questo senso penso che hai ragione: il solo è anche una dimensione confessionale, di confessione e introspezione e per questo motivo chiedo una grande disponibilità e pazienza da parte dell’ascoltatore, che è complice di questa mia solitudine e urgenza.
Fisiologia – e limiti – delle lamine
Le “lamine” non sono il vibrafono, direi invece che l’Assenza è il vibrafono. Mi riferisco con questo a ciò che manca allo strumento e nell’assenza lo caratterizza: per esempio il canto che è solo suggerito, la possibilità di cantare che può essere immaginata nonostante la resistenza fisica dello strumento a piegarsi alle necessità espressive della voce, alle imperfezioni del suono emesso. Si tratta in primis di un suono puro, quasi “sintetico” privo delle imperfezioni dello spettro degli armonici che caratterizzano il suono di tutti gli altri strumenti “nobili”, il loro timbro e il loro colore, voglio dire. Se non c’è questa caratterizzazione timbrica, un suono è sempre possibile, così un colore, un timbro e quello del vibrafono, “sta bene con tutto!”: però bisogna saper ascoltare e ascoltarsi nel contesto. In questo caso, nel solo, il contesto è solo immaginato, suggerito e l’ascoltatore è anche più libero. Ed è questo il punto: uno strumento è un mezzo per ri-trovare un punto di contatto nell’ascolto. E il vibrafono, per me, è proprio un meta-strumento, proprio come quando si progetta per modelli fisici e si crea, a partire da algoritmi di sintesi, uno strumento attraverso complesse procedure matematiche. Questa è l’idea per me, oggi, del vibrafono ed è davvero altro, così non lo intendo più all’interno del linguaggio del jazz e di nessun linguaggio ma come qualcosa d’altro. Con questo oggetto-strumento, nato per riprodurre alcuni effetti radiofonici e non come strumento musicale, non ho nessun debito con il passato e con la Storia anche se suono con due mazzuole, pollice alto –thumb up!– e posso imitare “la voce” di Milt Jackson a devo necessariamente usare la consistenza delle mazzuole Albright per esempio, così se voglio imitare lo stile di Bobby Hutcherson o di Gary Burton e di tutti i grandi maestri; mi diverto a suonare con quello stile, con quel peso e fraseggio sullo strumento; ma questo solo per me, in segreto. In questo periodo sto pensando al pezzo di Franco Donatoni, Omar, dedicato all’amico e Maestro Maurizio Ben Omar con cui ho studiato molti anni in Conservatorio e collaborato artisticamente su vari fronti; in Omar non c’è nessun legame con il passato, nemmeno con quel poco di jazz che si ritrova sempre nella scrittura contemporanea per vibrafono. (E Franco Donatoni il vibrafono lo intende proprio in questo senso, quale meta-strumento nella sua “scrittura cieca”).
Quando invece sono davanti al mio vibrafono oggi mescolo tutto questo, non in maniera premeditata e razionale ma in base al contesto e alle urgenze musicali del momento cerco di tradurre la “mia tecnica” che è una ‘tecnica cieca’ allontanandomi spesso dalla prassi vibrafonistica verso altri modelli che invento al momento con la pratica dell’errore. Grande ispirazione mi perviene dalle onde Martenot, per esempio, da una semplicità di esecuzione, diretta e di contatto evitando qualsiasi tipo di sofisticazione intellettuale o tecnica ma con una grande preparazione che mi impegna su diversi fronti, strumentale e teorico; o partendo da una certa idea di suono immaginato, elettronicamente concepito: di sintesi. Il vibrafono può essere anche un sintetizzatore, giusto? Può essere ciò che voglio, in quel momento. In effetti posso dire di essere un polistrumentista (la mia pratica esecutiva privata è davvero molto varia: dal pianoforte allo scacciapensieri, dal sintetizzatore alle percussioni etniche, dal berimbau al salterio, al flauto, al canto alla parola…) che nel vibrafono ha trovato un terreno di sintesi di sensibilità e approcci sonori possibili. Sempre oltre la musica in sé ma guardando al contesto sonoro nel suo insieme: al paesaggio sonoro che ci circonda e ci in-forma.
In questo progetto in solo ho pensato di concentrarmi non tanto sul suono dello strumento quanto sulla mia neo-lingua specifica e sull’armonia intesa in senso “anarchico” come avrebbe detto John Cage (anche se in questo caso specifico c’è molto di personale e stilisticamente più connotato, e questo devia il mio percorso rispetto a una ricerca più rigorosa che porto avanti da anni insieme a Fritz Hauser con Structuring The Silence dove l’improvvisazione è costretta e la personalità del singola ridotta a presenza).
Si può sentire in questo album un mio approccio più verticale, essenzialmente armonico; dalla singola nota alle quattro voci (o cinque!) possibili; e sempre e solo con quattro mazzuole fisiche in un lungo solo diviso in quattro parti, con le due parti centrali che non sono altro che una estensione della forma blues su tutto lo strumento. Ecco, il blues! Per me questo è un approdo concettuale fondamentale che va oltre la semplice forma di dodici misure o altro. È una attitudine esplorativa tra maggiore e minore, tra esterno e interno: dentro/fuori. Questa è davvero la differenza a livello anche esistenziale, per quanto riguarda la concezione del suono. Una terra di mezzo possibile tra est e ovest, nord e sud un luogo di dialogo tra idiomi, lingue e tradizioni, per me è anche uno strumento concreto di pacificazione e comprensione della complessità umana e naturale e una forma di preghiera, di dialogo con l’Altro sopra di noi: lo spirito, Dio. Ed è possibile pensare oggi tutto ciò? Forse si. Difficile farne esperienza. Diciamo che, concretamente, ho tentato di sviluppare una concezione per registri sullo strumento, si tratta materialmente di tre ottave da fa a fa ma c’è molto di più e si cerca sempre di evitare l’orizzontalità dello strumento a tastiera (e questo mi fa pensare a una intenzione bachiana): non su è giù ma dentro, in profondità verso un mondo sonoro più profondo e più denso. E questo lo si può fare solo sviluppando un pensiero armonico anarchico ma spiritualmente concentrato e presente.
Questa è la fisiologia dello strumento, una successione di lamine in progressione logaritmica, di cui si deve evitare la linearità apparente delle scale, degli arpeggi e di tutto un bagaglio percussivo di cui è meglio sbarazzarsi. Verso il canto, un immaginario sonoro esteso.
Poi c’è la gravitazione che sposta e impone, le braccia, i polsi e le dita con la loro meccanica e struttura e la mente che osserva: è tutto molto visivo, fisico e corporeo come memoria cinetica con il rischio di eludere l’ascolto. Tecnica cieca, appunto. Ecco ci tengo a dire che non voglio “eludere l’ascolto” ma respirare e risuonare con lo strumento, attraverso il corpo… (è il corpo che pensa!) per questo è forte il riferimento all’euritmia e al pensiero di Rudolf Steiner per me, maggiore/minore e una certa “vocalizzazione” del gesto. Sempre dentro l’atmosfera di quinta! Euritmia come linguaggio visibile, ecco questa definizione andrebbe bene per il mio approccio al vibrafono: vibrafono, linguaggio visibile.
Esaminando l’evento sonoro ad un livello molecolare: un’idea della Vibrazione.
Si ritorna inevitabilmente a Rudolf Steiner laddove, nell’Essenza della musica, parla dell’unico suono come unità della vibrazione. Lo strumento è un tutto, un corpo che risuona e da questo punto di vista non si può che partire dalla scala cromatica: l’intero cromatico. Sono dodici note, o frequenze, messe semplicemente in relazione tra loro. Lo spazio è il semitono che può essere ampliato attraverso l’immaginazione e alcune prassi non convenzionali (la preparazione dello strumento è un tentativo in questo senso). Concettualmente parto sempre da un’idea di suono e mi affido al corpo e ascolto solo dopo; mai prima, ma solo e sempre dopo. Rispondo al mio corpo, semplicemente. Il suono non può essere pensato prima, deve essere ascoltato invece accettando quello che accade con minime correzioni tecniche, deviazioni, aggiustamenti di stile e di linguaggio ma tutto deve avere origine dal corpo e dal movimento. Credo che questo comporti una consapevolezza superiore e l’accettazione della vita nella sua continua metamorfosi, di nascita e morte; anche i suoni nascono e muoiono e noi conserviamo il ricordo, l’impronta anche semplicemente di una giornata “per vibrafono solo”.
Tentando una descrizione di certe Tue soluzioni formali, avrei anche azzardato la definizione “labirintico” (labirinto come potente immagine, dalle implicazioni simboliche e psicologiche)
Labirintico come conseguenza di un intrecciarsi di pensieri, atti, gesti… ma, devo confessarti che io in questo labirinto spesso mi perdo e trovo soluzioni possibili anche se non credo di essere andato oltre un istinto che mi ha sempre accompagnato dall’inizio, unito a un piacere della ricerca e della scoperta dentro e con il suono e con tanti limiti oggettivi. La mia lentezza nella ruminazione, come dicevano i mistici; e una digestione lentissima. Tu parli di soluzioni formali giustamente ed è quello da cui scappo: la Forma. Per questo mi piace l’improvvisazione libera, la condizione di perdita, di deriva; non credo che il controllo sia necessario per la Forma, è più importante la fede, uno spirito dionisiaco, una musicalità contro ragione; insomma uno stato di presenza con e attraverso il proprio strumento. L’uscita dal labirinto è forse la soluzione, sempre rimandata ma attesa come uno stato quasi miracoloso di illuminazione sonora e spirituale. Per ritornare sempre a una dimensione più quieta, ragionevole, borghese come questa nostra conversazione; quello che chiamo lo spirito di Goethe. Credo che alla fine la soluzione sia sempre democratica, necessariamente: Voltaire insegna. Tollerante! E la soluzione, se vuoi, è l’ascolto e il riconoscersi nel dialogo.
Ti rubiamo una frase: “Pensare la Musica”
Certo, ma: “Pensare la Musica: con il Corpo”. La mente osserva ed è il corpo che pensa. Questo mi è chiaro, per esperienza; altrettanto chiaro è il fatto che la teoria musicale serve in negativo; la musica è presenza e non può essere compresa con la logica di causa effetto, perché qui è l’effetto che determina la causa. Non c’è storia della musica ma stati momentanei del musicale che è lo spirito che anima e informa tutti i suoni esistenti. L’improvvisazione, così come la intendo e vivo, è una grande perdita, si tratta di smemoratezza, per citare una mia raccolta poetica: si tratta di orchestrate collisioni e di stati della coscienza risvegliati da suoni in relazione tra loro, o meglio semplicemente simultanei, sincronicamente esistenti in uno spazio tempo nella nostra fugace esistenza e per questo intesa e vissuta come pratica curativa: liberata non solo dal peso della gravità, della vita e della cultura, ma estendente il campo di percezione nella riduzione dell’Ego; No-Ego, in improvisation, quindi. Suono da solo per dimenticare me stesso! E questo risulta oggi molto anti-jazz, non credi? Nel revival divistico narcisistico del gioco delle identità indotte. Non credi?
Si stenta a seguire le Tue esternazioni, e già limitandosi a quelle discografiche si potrebbe parlare più che di una discografia, di un’autentica letteratura. Vorremmo andare ad esempio ai recenti Milano Dialogues, a loro volta afferenti alla produzione Leo Records?
In effetti considero tutti gli strumenti validi e utilizzabili: la parola, il suono, l’immagine. Ma paradossalmente parto sempre dal linguaggio anche se quello che faccio e come opera è sempre in contraddizione con questo presupposto. Le mie deviazioni e i miei scarti nascono da una necessità di costruire un contesto reale attorno al mio lavoro. Per reale intendo “poeticamente consistente”, simile a una tradizione consolidata, a una ritualità vissuta come esperienza della vita e del suo processo costante di morte e rinascita. Ma personale, individuale. Il mondo attorno non mi basta come sfondo perché quello che ci vogliono far credere è che sia sufficiente la partecipazione, il consumo e il consenso: io chiedo invece di essere presente a me stesso, di cercare dentro e non fuori un significato reale, spirituale, nel suono e nella vita. E l’isolamento mi fortifica e mi esalta! La musica non è un atteggiarsi, un tendere verso un bello esteriore; non mi sento un musicista in questo senso, ma con la musica, con la mia musica, credo di poter confermare la mia presenza spirituale, la mia voce nel coro dell’umanità che oggi rischia di rimanere senza più uno spartito da decifrare. Sono convinto della necessità di stabilire un rapporto intimo, personale, con le cose; ancora John Cage per me rappresenta un modo non-violento, intensamente consapevole, dell’esistenza dai più piccoli suoni verso tutte le creature, francescanamente, e della loro fondamentale importanza per la nostra sopravvivenza. Mi piacerebbe che tutto il mio lavoro fosse compreso come uno sforzo di ritrovare una unità dell’esperienza, anche in questa nostra conversazione che illumina l’ascolto, per il domani e ci da la speranza.
Con Leo Feigin ho trovato una intesa inaspettata forse dovuta anche alla novità delle formazioni che mi sono impegnato a creare: sax soprano, trombone, voce e fisarmonica microtonale, elettronica e poesia sonora sempre in dialogo con il vibrafono ma in una continua metamorfosi. Con Harri Sjöström, Veli Kujala e Giancarlo Schiaffini, (e poi Elliott Sharp, Steve Piccolo, Steve Day) abbiamo registrato due album in quartetto, in solo, duo e trio sempre ai confini del temperamento equabile. Come sai il vibrafono ha una intonazione fissa e solo la densità e la velocità dell’attacco può suggerire un contesto armonico inequabile. Il dialogo con la fisarmonica microtonale di Veli mi ha permesso di immaginare un vibrafono non temperato. Questo ha spinto molto la mia immaginazione ad uscire dalla consueta staticità dello strumento. Questa dialettica interna alla densità armonica, aggrappandomi ai suoni vocalici di Giancarlo e alle impennate grumoso di Harri hanno portato a un paesaggio sonoro davvero liminare. Un momento di passaggio verso una musica inaudita, nata anche questa volta dal corpo e dall’improvvisazione libera. Ma sempre nell’immaginazione del possibile.
Vi sono anche esperienze euro-free per l’etichetta Hat Hut.
Con Hat Hut è già uscito, nel 2020, il mio quartetto Prismo dove ho ampliato il mio approccio più rigoroso all’improvvisazione, sviluppando quanto già in nuce nei number pieces di John Cage, con l’uso dei time bracket(s) che vincolano l’improvvisazione e aiutano a non ascoltarsi mettendosi in relazione diretta con il tempo, che è inteso come una sovra-struttura temporale flessibile, non vincolante ma presente. Nello spazio si invera la forma, come scheletro temporale, che io determino attraverso procedure casuali e utilizzando lo stesso software creato da Andrew Culver per John Cage e oggi disponibile gratuitamente on line: ic. Così con Prismo, insieme a Fritz Hauser con cui ho iniziato questo percorso di ricerca molti anni fa, Martina Brodbeck al violoncello e mia moglie Francesca Gemmo al pianoforte, ho voluto estendere questo processo, dal duo al quartetto fino al “giardino” di Mantova durante il recente concerto nella Sala dei Cavalli di Palazzo Te per Mantova Musica, nella stagione Eterotopie diretta da Leonardo Zunica che ha idealmente chiuso questo primo momento di ricerca con una apertura sul paesaggio sonoro, similmente al mio lavoro di field recording Mahler (in/a) Cage dell’anno scorso per Gruenrekorder insieme all’amico Roberto Masotti, che non è più con noi e che ricordo con grande riconoscenza. Recentemente è uscito un progetto in quartetto con riferimento joyciani sia di concezione che di linguaggio: I Dreams I Was An Earopean dove, con Phil Minton alla voce e tromba, Roger Turner alla batteria e alle percussioni e Giancarlo Schiaffini al trombone si è idealmente condiviso una improvvisazione “europea” come Earopean, cittadini acustici di una Europa ideale dell’orecchio: dell’ascolto! In fondo credo che una società aperta non può che passare dall’ascolto; in fondo tutti i regimi totalitari, rispetto al passato, hanno bisogno più dell’occhio e dell’immagine che dell’ascolto e oggi questo è drammaticamente evidente.

Molte Tue registrazioni hanno abitato con ampiezza un sottofilone avant-garde (piuttosto sfaccettato) della label Dodicilune.
Sono molto riconoscente a Maurizio Bizzochetti e Gabriele Rampino che hanno condiviso con me numerosi progetti discografici, differenti e contraddittori; sempre all’interno della dialettica delle anime contrapposte del jazz in tutto il suo sviluppo storico. Ho potuto permettermi di incidere con il pianista Billy Lester, in un idioma puramente jazzistico a due mazzuole come omaggio simbolico e ideale ai grandi maestri del vibrafono nel jazz; all’inizio ho comunque proposto un progetto di transizione con il mio Axis Quartet che mi ha permesso di superare tutto il periodo di studio classico-conservatoriale per approdare a progetti sempre concentrati attorno a un nucleo problematico e critico personale, intimo ed estraneo a convenienze e contingenze culturali: così e nato il Fakebook di Alvin Curran, con Alvin Curran stesso; gli Esercizi di improvvisazione di Luc Ferrari e altre collaborazioni, Syzygy con Elliott Sharp, l’incontro con Andrea Centazzo e, con Giancarlo Schiaffini, l’immersione monkiana: prima decostruito e poi con il “piccolo” Monkish. Credo, con questo, di aver contribuito ad ampliare l’orizzonte della casa discografica salentina mettendo in crisi troppo rigide certezze di stile e di genere oggi determinanti un contesto discografico da una parte fluido e liquido, sul versante del consumo e dell’ascolto, e rigidissimo sul versante della proposta e della produzione-distribuzione. Una rigidità dovuta agli algoritmi e ad una concezione settoriale e di mercato della musica come prodotto e merce e non come esperienza. Ma io mi muovo bene in questo territorio di confine, in povertà s’intende, senza ambizioni terrene particolari anche se cerco sempre di tenere d’occhio la via di fuga mantenendo la porta sempre aperta per poter smettere e riprendere da qualche altro punto del percorso.
Quali pregi ma anche quali mali sono attribuibili alle avanguardie contemporanee? Ciò da un punto di vista sia di creativo che di fruitore (o l’argomento è ormai troppo vasto ed eterogeneo ?)
Certo la domanda è davvero molto complessa e presupporrebbe una risposta altrettanto articolata. Le avanguardie hanno, per quanto mi riguarda, una importanza centrale nel metodo: un metodo dadaista il mio, dunque un non metodo. Sono state la base necessaria di consapevolezza da cui io sono partito, gli strumenti li trovo sempre a disposizione su quel tavolo iconoclasta ma in un dialogo profondo con i motivi della storia, così posso permettermi di ritrovare il canto Gregoriano per esempio, liberato da tutta la sovrastruttura storico-critica, dalla Tradizione quasi come un fanciullo, direttamente nell’esperienza del canto. Le avanguardie contemporanee sono estranee a tutto questo, semplicemente ripropongono alla superficie ma non possono praticare la profondità, ripeto: il senso più intimo della libertà conquistata da Marcel Duchamp o da Luigi Russolo con tutte le conseguenze che questo ha comportato. Credo che solo John Cage abbia compreso il portato fondamentalmente spirituale delle avanguardie storiche, il resto della contemporaneità ha sfruttato una certa supposta facilità verso il consumo come una forma di massificazione dell’arte dove l’artista è inteso come Artista e modello romantico-ribelle immerso nel sentimento e nella emotività ancora, in fondo, tutta neo-romantica, modello di vita e di consumo e spreco. Abbiamo sotto gli occhi questo enorme danno, la perdita del contatto con se stessi, con la propria unica e irripetibile presenza a favore del consenso e del consumo. Il pregio è dunque l’esoterismo dell’avanguardia, il suo lato oscuro, iniziatico che può essere colto e permette la sopravvivenza della Forma; i mali sono tutto ciò che pertiene l’essoterismo, il lato esteriore della forma che se diventa forma di vita dello scarto non può che portare alla nostra definitiva estinzione. Hegel parlava di morte dell’arte, penso a Pier Paolo Pasolini e alle sue vitali contraddizioni. L’avanguardia per me è lo sguardo fanciullo e la libertà dell’esperienza.
Discutere con Te di Estetica presupporrebbe disporre di consistente tempo, oltre a spazi enciclopedici, ma vogliamo provarci…
Nietzsche sostiene che il mondo può essere giustificato solo esteticamente e non eticamente. La Morale non fonda il mondo ma solo l’Estetica giustifica l’esistenza. Credo che nell’oggi si avveri una fusione tra etica ed estetica, che io scrivo con la lettera minuscola. L’ideale del bello come verità oggettiva, l’ideale kantiano, è definitivamente perduto anche se sopravvive nell’inconscio delle masse travestito da consumo. Che orrore! È lo spirito di Socrate e della Ragione che ci soffoca, direbbe ancora il buon Nietzsche. Io non mi ritengo un “niciano” anche se amo leggerlo e ogni volta mi rapisce perché ne comprendo il pericolo. E questo vale anche per Wagner a cui preferisco il mistico Mahler. Comprendo altresì la necessità di una riscoperta spirituale necessaria e credo che la nostra cultura sia ad un punto di rottura definitiva: le chiese si svuotano e Dio è completamente assente dalle nostre prospettive di vita. L’Estetica come io la concepisco è un riconoscere nel mondo sensibile, attraversi i sensi, una presenza sovra-sensibile; in questo senso la musica è una esperienza trascendente. Rudolf Steiner riteneva possibile dimostrare l’esistenza di Dio scientificamente attraverso l’ordine degli armonici, questo significa che la nostra percezione sensibile ci permetterebbe di fare esperienza del divino. L’Estetica può trasformare l’esperienza sensibile in esperienza spirituale, l’arte deve tornare ad essere Arte ma questo è possibile solo all’interno di un percorso di iniziazione consapevole e cosciente. Il post-modernismo ci ha illuso di poter semplicemente giocare con i linguaggi e gli stili, come oggi l’intelligenza artificiale che è la realizzazione dell’incubo ‘presentista’ delle società avanzate. Una grande vacanza tra oggetti morti, privi di reale significato: nel silenzio di Dio. Però non credo nei grandi ritorni, non credo nella Tradizione. Credo nel rinnovarsi di esigenze e necessità profonda che la musica può portare ad evidenza. L’esperienza estetica è sempre anche una esperienza spirituale, quando è autentica presenza e non religiosa, come riscoperta dell’Aura. Questo per me è oggi il pensare l’Estetica, in questo caso con la lettera maiuscola!

Non riesce inopportuno, a questo punto, discutere anche di Etica (nella proposta artistica, nella performance, etc.)
In parte ho già risposto ma ribadisco il concetto: l’etica e l’estetica non possono che fondersi in una esperienza vivificante del presente. Questo nasce da un rapporto rinnovato, dialettico, non più mediato ma complesso e unitario con la Natura, con il nostro ambiente: un rapporto ecologico. In questo senso posso dire che la direzione della Laudato si di Papa Francesco è l’unica possibile oggi, con tutti i limiti evidenti della Chiesa Cattolica, ma io comprendo lo sforzo nel ritrovare una unità di fondo. Il lasciare un segno è un gesto etico se inserito in un contesto reale di rispetto e riconoscimento reciproco, di ascolto; ed è un atto estetico nella sua perfettibilità, nella sua possibilità di riverberarsi nel nostro intimo attraverso tutte le creature che stanno scomparendo, si nascondono o sono invisibili ai nostri occhi coperte dal rumore del mondo sempre più violento e indifferente. Questa è la nostra lotta come umani. La musica è un contributo che si misura nel grado di armonia che riesce a concepire tra forma e intenzione, tra ascoltatore e interprete che rimane sempre un medium, un mezzo perché ciò si realizzi.
“Musica, Medicina Mentis”: oggi.
Certo, la musica è una grande terapia: prendersi cura dei suoni, di tutti i suoni significa prendersi cura del proprio essere. La mente osserva mentre il corpo pensa. La musica è “medicina mentis” a un grado superiore, intangibile ma presente. La sua presenza è la cura. Questo per me. In fondo una vita senza musica sarebbe un grande errore, non è vero? E questo è stato detto da Nietzsche se non sbaglio. Ma oggi la musica non basta, necessario è andare dentro i suoni, vivere con essi e attraverso di esse comunicare con tutti: animali, vegetali. Nella compresenza dei vivi e dei morti direbbe Aldo Capitini, un grande maestro!
Modelli Virtuosi, Cattivi Maestri… o i concetti andrebbero rivisti?
Quanto ai primi, si è detto: Aldo Capitini e la non violenza. Un grande maestro! Nonviolenza si scrive tutto unito in una parola sola, questo me l’ha insegnato una tradizione liberale e radicale, a cui devo la mia residua cultura politica depurata dal dogmatismo troppo rigido di un certo marxismo di provincia. Ricordo di essermi sempre cercato e compreso all’interno di una tradizione liberale e democratica, da Mazzini a Croce in poi, con innesti libertari e anarchici, penso a Thoreau, Emerson e la grande tradizione democratica americana; i fratelli Rosselli, Piero Gobetti, l’antifascismo di Calamandrei, Danilo Dolci, il partito radicale e Marco Pannella e tutti i movimenti libertari: Ivan Illich, Feyerabend e anche un certo libertarismo. La mia prima giovinezza è stata demo-proletaria ma, forse grazie anche al catto-comunismo di Mario Capanna e all’opposizione ad un certo dogmatismo di una parte della mia famiglia di stampo comunista, mi sono avvicinato a un cristianesimo anarchico: Ellul per esempio che oggi è fondamentale nell’opposizione alla deriva tecnologica, al bluff tecnologico come lo chiamava lui. Riscoprire anche una attitudine pedagogica che possa partire dall’esperienza artistica, questo oggi è quasi impossibile nella scuola aziendalizzata ed elevata a sistema di valutazione quantitativa. Per questo mi sono impegnato a rifondare la mia prassi educativa a partire dalle scuole primarie, come maestro steineriano in un percorso costante di ricerca. E in questo ci sta anche Don Milani, priore di Barbiana che aveva, come me, un diploma in pittura conseguito all’Accademia di Belle Arti di Brera. Sono dettagli che servono a creare rapporti. E poi ci sono i maestri che ho conosciuto e con cui ho studiato: Luciano Fabro, Francesco Leonetti, Roberto Sanesi, Luigi Pestalozza…
Il pubblico di oggi è servito, ma anche schermato dalla dimensione web, che ha incrementato in termini esplosivi la disponibilità di materia musicale (per non dire della frequente fruizione gratuita) e ha certamente stravolto la relazione artista – pubblico (vale nei due sensi)
Oggi la musica vive in una condizione di liquidità, se facciamo nostra la definizione di Bauman di società liquida; questo comporta una perdita di controllo da parte degli artisti che ritengo anche positivo e interessante, una riduzione dei profitti da parte delle case discografiche, una diffusione orizzontale di progettualità e possibilità di creazione a favore dei grandi profitti di poche piattaforme che, ridefinendo i limiti di generi e stili, individualizzando l’ascolto e premiando la quantità a discapito della qualità hanno impoverito il contesto musicale, frammentandolo e riducendolo a discount. Oggi, per tutti, la musica è gratuita. È un servizio, un sottofondo costante delle nostre vite. Questo comporta un abbandono della musica come esperienza e atto di pensiero. Ciò in cui credo deve sopravvivere in una nicchia di resistenza e questo non mi spaventa. Sono consapevole comunque della proporzionalità tra distribuzione, condivisione, consumo e impoverimento di significato e senso del suono, spogliato dal suo valore di mezzo per ascendere a dimensioni di profondità e presenza spirituale e di vita a favore di un semplice divertissement narcisistico e sterile che rimane alla superficie di un presente totalizzante.
Vorremmo andare alla Tua partnership, di vita e d’arte, con la pianista Francesca Gemmo?
Francesca è mia moglie, ed è pianista e compositrice. La nostra vita rimane segreta ai processi nascosti e intimi della musica che cerchiamo di mantenere in una posizione di assoluta chiarezza e trasparenza perché ne supponiamo e conosciamo la pericolosità intrinseca di certe dinamiche e di un carico anche emotivo che una attività artistica condivisa può portare con se. Ci siamo conosciuti in Conservatorio a Milano, lei nella classe di composizione io in quella di strumenti a percussione, elettronica e jazz. Poi ci siamo sposati e da lì è iniziato il nostro percorso di vita: prima lo studio con i nostri strumenti, poi la casa… Il nostro rapporto si è consolidato nel tempo anche grazie alla musica. Non è facile parlare di tutto questo, le parole semplificano e non permettono di accedere ai livelli più profondi che sono spesso semplicissimi: ci si piace e da lì nasce tutto. Come l’incontro con un suono! Mi piace pensare che il suo modo di essere, durante le nostre giornate, i nostri progetti e tutti i nostri sogni si siano sempre armonizzati con i nostri impegni, i nostri gatti, tutte le nostre cose: libri, strumenti, dettagli in un progetto complessivo di vita condiviso. Nonostante tutto guardiamo sempre avanti, oltre a guardarci negli occhi.
Importante è sempre il contatto, ma per ora un nostro progetto in duo è ancora rimandato. In tutti i nostri progetti abbiamo sempre cercato di condividere un clima, un contesto, evitando che il nostro legame potesse ostacolare il dialogo con gli altri e privilegiare la nostra posizione.
…cos’altro c’è dietro l’angolo?
Dietro l’angolo è in preparazione un progetto discografico in duo con Evan Parker, il volume otto della collana aboutCage in duo con Fritz Hauser, una partnership con Nuova Consonanza e Fondazione Scelsi insieme al flautista Gianni Trovalusci e Francesca (Gemmo), due progetti con Steve Piccolo e uno dedicato a Pietro Grossi con Gruenrekorder, il mio duo con Giancarlo Schiaffini e una registrazione in duo con Giovanni Maier, un invito a Berlino per ottobre al festival Soundscape di Harri Sjostrom, il libro Bacchette magiche in conversazione con Andrea Centazzo per Manni Editore e altri progetti discografici nel cassetto di cui ti parlerò più avanti.
Mica poco. Ora, una citazione in libertà:
Amai trite parole che non uno
osava. M’incantò la rima fiore
amore
la più antica del mondo.
(Umberto Saba)
…ne siamo toccati.
Photo Credits:
1 © Luisa Mizzoni
2, 3 © Luciano Rossetti
4 © Francesca Gemmo
 Sergio Armaroli
Sergio Armaroli