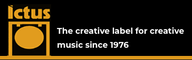L'intervista
di Enzo Boddi



Dialogare con Sergio Armaroli offre l’opportunità di rompere gli schemi convenzionali dell’intervista. Il suo eloquio è fluente, ricco, ricercato e al tempo stesso denso di riferimenti e citazioni che riflettono un’ampia gamma di interessi: per la letteratura, la poesia, la filosofia, le arti figurative e il cinema. Lo stesso Armaroli dipinge, compone poesie e scrive saggi. In questo senso, abbiamo a che fare con un musicista del nostro tempo, che respira e assorbe stimoli da varie discipline. Vibrafonista e percussionista, Armaroli proviene da solidi studi di conservatorio e da esperienze in orchestre ed ensemble di matrice classico-contemporanea. Tuttavia, pratica diffusamente l’improvvisazione, in particolare sul versante jazzistico. Non a caso, ama definire il jazz - che concepisce come un linguaggio vivo e interattivo - la propria «lingua materna». La sua produzione discografica dell’ultimo quinquennio, in buona parte disponibile su Dodicilune, è copiosa e variegata, essendosi sviluppata su più fronti. Da una parte, Armaroli ha esplorato il repertorio di autori come Christian Wolff, Luc Ferrari, John Cage e Alvin Curran. Dall’altra, ha intrapreso proficue collaborazioni con Andrea Centazzo, con colleghi percussionisti come Roger Turner e Fritz Hauser, con il sassofonista finlandese Harri Sjöström, con Elliott Sharp e – per ultimo ma non ultimo – Giancarlo Schiaffini, insieme al quale ha affrontato gli autori sopra citati. Il sodalizio con Schiaffini si è tradotto anche in una singolare indagine su pagine di Thelonious Monk, documentata da Dodicilune. Pur nella loro diversità «Deconstructing Monk In Africa», inciso in duo, e «Monkish», in quartetto con Giovanni Maier al contrabbasso e Urban Kušar alla batteria, sono efficaci esempi di come si possa recuperare e interpretare l’essenza della musica di Monk. In entrambi i lavori Armaroli affianca al vibrafono e a un nutrito armamentario percussivo un balafon cromatico, con esiti sorprendenti.

Analizzando il tuo percorso, emerge il profilo di un musicista versatile in equilibrio tra improvvisazione e musica contemporanea, ma dall'anima e dallo spirito profondamente jazzistici. Ti riconosci in questa definizione?
Come mi è stato insegnato, responsabilità è la capacità di rispondere e quindi ci proverò. Non ho mai creduto che la linearità di un percorso di studio e di ricerca fosse una garanzia; anzi, ho sempre pensato evangelicamente che «perdendo la propria vita» l’avrei ritrovata e ho sempre fatto tesoro di tutte le mie crisi. Detto questo, mi riconosco in questa tua definizione anche se ci sono dei distinguo da fare. In primo luogo, è proprio l’equilibrio che mi interessa ricercare costantemente. Dopo anni di esperienza in orchestre di musica classica, ensemble di musica contemporanea e apparizioni solistiche, uno dei miei primissimi progetti discografici, «Prayer And Request», riportava come esergo una preghiera di ascolto: alla ricerca di un asse di equilibrio. Quella ricerca continua ancora oggi, ogni giorno mi sveglio e cerco quell’equilibrio instabile. La musica è movimento, per sua natura versatile e così, se si vuole essere musicali e non semplicemente musicisti, bisogna rispecchiarsi in questa versatilità ed essere preparati a un cambiamento costante. Per me non esistono stili, generi, né sovrastrutture storico-critiche quando metto in atto un progetto. Certo, sono consapevole che la lettura dei fenomeni musicali passa attraverso questo filtro interpretativo, ma credo che la musica vissuta non sia altro che un insieme di pratiche messe in relazione tra di loro ed esercitate all’interno di un’identità mobile e in costante trasformazione. Per me, che sono cresciuto attraverso l’improvvisazione come dato spontaneo, è stato logico avvicinarmi alla musica contemporanea e all’improvvisazione che sommate danno come risultato un jazz vivo, necessario, in evoluzione e non una semplice collazione di tic, idiomi e modi assunti passivamente. Parafrasando, posso dire che il jazzista non è l’insieme dei suoi vezzi. Siamo l’insieme dei nostri sogni e delle nostre necessità ed io ho sempre privilegiato un percorso laterale e solitario. Credo che lo sforzo principale sia quello di chiarire a se stessi una direzione, magari nelle condizioni più avverse! Così è stato per me e il mio rapporto con la musica contemporanea ha costituito una parte della mia langue maternelle, che è il jazz; e può essere il jazz solo se inserito nel contesto più ampio della musica contemporanea, la musica che accade ora. Oggi accade tutto sincronicamente; tutto ci è contemporaneo e allo stesso tempo ci sfugge. Per me si è trattato di studiare moltissimo la struttura della musica, la sua architettura e questo è stato possibile farlo solo dopo Schönberg. Da percussionista posso aggiungere che è stato possibile solo dopo Beethoven e non prima, mentre con Cage si è raggiunto un pensiero complessivo sul ruolo dei suoni fino a una categoria che io definisco «della percussione», dove tutti i suoni sono esperibili all’interno di un pensiero più ampio che comprende il loro essere, il loro ambiente nella triplice funzione di ascolto, composizione ed esecuzione. Studiando gli strumenti a percussione in un percorso accademico conservatoriale non si può che studiare la musica contemporanea che per quanto mi riguarda non corrisponde ad uno stile idiomatico specifico e riconoscibile, ma a un modo di vivere i suoni che io definisco instabile e strutturale. Così, per me l’improvvisazione ha rappresentato un viatico che ha aperto la scatola teorica del serialismo e di tutti gli ismi coevi e, abbandonando anche la scrittura, ha ritrovato la struttura nell’ascolto, nel suono in sé. Per questo motivo trovo sempre regressivo il tentativo di ricercare nella scrittura un’idea di struttura, e lo dico da compositore autodidatta che nonostante tutto ancora scrive. Cage mi ha insegnato che nell’atto dell’ascolto troviamo la forma. Ma di quale ascolto si parla? Forse di un «ascolto ridotto», come avrebbe detto Pierre Schaeffer? O l’improvvisazione mette in atto un ascolto profondo come nell’esperienza di deep listening di Pauline Oliveros? Sono tutte domande aperte che indicano una strada alla ricerca dell’equilibrio di cui parlavo all’inizio.

È naturale che questi tratti distintivi della tua formazione e della tua poetica ti abbiano poi condotto a collaborare intensivamente con Giancarlo Schiaffini. Quali altri aspetti vi accomunano?
Giancarlo mi è vicino in questo percorso solitario di confronto tra esperienze contemporanee e jazz e la sua fine come linguaggio connotato storicamente. Ho incontrato Giancarlo Schiaffini molti anni fa all’interno di un progetto di ensemble del Conservatorio di Milano dal nome indicativo: ImprovvisoFantasia, per una serie di concerti dedicati a un repertorio laterale tra scrittura e improvvisazione, con musiche di Cage, Stockhausen, Scelsi e altri, diretto dal Maestro Giuseppe Giuliano che è stato il vero artefice del nostro incontro. Ho sentito la necessità di sfuggire al compito scolastico del buon musicista di conservatorio. Così gli ho scritto una lettera a mano in cui mi dichiaravo per quello che ero: un musicista in crisi! All’epoca volevo abbandonare il rituale del concerto e provare a percorrere delle strade laterali con un progetto discografico dedicato a Christian Wolff e a musiche originali dello stesso Schiaffini («Micro And More Exercises», inciso con Dodicilune) che mi potesse permettere di costruire un dialogo anche para-jazzistico, ma di certo memore della grandezza e della centralità dell’esperienza di Giancarlo con Luigi Nono e in particolare con Franco Evangelisti. La musica di Luigi Nono ha vissuto una reale crisi tra gli anni Settanta e Ottanta con l’abbandono di una scrittura totalizzante e il ritorno al suono grazie alla collaborazione con solisti di grande apertura mentale e bravura. Tra questi, Giancarlo Schiaffini ha rappresentato il ponte più solido tra il jazz più progressivo, il free jazz romano dei Sessanta - forse la prima espressione consapevole di un jazz adulto in Europa slegato dalla colonna sonora degli Stati Uniti dell’epoca - e l’avanguardia. Per me è stato necessario mettermi in rapporto con quel passaggio di pensiero e di pratica che la musica e la vita di Giancarlo rappresentano. Ho anche capito che il virtuosismo è un atteggiamento della mente ed ha poco a che fare con le sole mani: è l’intelligenza del pensiero e del suono. Giancarlo mi ha anche insegnato che «il suono non esiste» in quanto fenomeno fisico e quindi il virtuosismo non può che essere «cosa mentale», parafrasando Leonardo da Vinci.

«Monkish» ribadisce il vostro amore per Monk dopo il precedente «Deconstructing Monk In Africa». Sembra che stavolta abbiate optato per un procedimento più jazzistico, benché l'impiego del balafon in brani come Bemsha Swing o Blue Monk sia del tutto eterodosso. Avete individuato nel blues e nelle sue radici dell'Africa Occidentale subsahariana il minimo comun denominatore?
Parlando di jazz come linguaggio non mi sono mosso diversamente da te. Quando mi avvicino al repertorio mi sento un saggista, uno studioso e un antropologo che si appropria di tutte le affinità, le debolezze e gli idioletti monkiani. Perché Monk? Per me è stata immediata e ovvia la comparazione tra l’avanguardia, una certa avanguardia dagli angoli brillanti e la musica logica, strutturale, coerente di Thelonious Monk. In questo mi ha influenzato la posizione di Jean-Luc Godard: un critico prestato al cinema. Io mi sento spesso un critico prestato al jazz quando mi relaziono con il repertorio storico. Come vedi, anche in questo c’è molto Monk. Il suo presunto dilettantismo pianistico è un’apertura alla percussione come categoria, se pensiamo anche alla musica di Bartók. L’amore per Monk l’ho ereditato dall’ascolto di Steve Lacy, che ho molto amato e persino imitato sul vibrafono come un paradosso apparente. Secondo il concetto di Museo e l’idea del Catalogo che applico sempre con libertà e rispetto agli strumenti extra-occidentali, ho pensato di ri-leggere la musica di Monk alla luce delle radici - supposte e ipotetiche - di una musica africana che forse non esiste realmente. Importante per me è definire la mia posizione in base al punto di osservazione. Il punto focale non è fisso e la musica di Monk permette questa mobilità. Il balafon rivitalizza il mio background vibrafonistico e marimbistico: lo contestualizza e lo apre. Lo strumento che ho acquistato da Bara Gnouma in Burkina Faso è davvero unico! Per me non c’è dubbio: il canto è Africa. Se suono il vibrafono, bene; se suono la marimba, altrettanto bene; ma in questi casi prevale una certa distanza, un’opacità dovuta alla formazione culturale che prevale e pre-ordina. Quando suono il mio balafon invece mi avvicino alla Natura che in musica è canto, non come melodia ma come esistenza, e necessita dei suoni e del loro essere nel tempo. Una sensazione di solidità e forma. Sul blues invece si dovrebbe fare un discorso a parte che esula dalle dodici misure AAB per concentrare l’attenzione sul concetto di necessità in musica. Il blues rimane il sigillo che testimonia la presenza di un suono, qualunque esso sia; per me riguarda meno il sentimento e investe del tutto la forma. Per paradosso, quando voglio essere in-forma mi rivolgo al blues e la musica di Monk mi permette sempre di accedere, con immediatezza e semplicità, al nucleo generatore del linguaggio del jazz nella sua essenza strutturale. Questa unità intervallare avvicina la musica di Monk alla grande tradizione del Novecento e delle avanguardie che hanno inteso indagare il tessuto connettivo della musica abbandonando la deriva romantica che purtroppo ci pervade e ammorba ancora oggi!

Per contro, in «Deconstructing Monk In Africa» tu e Schiaffini avevate operato con modalità assai diverse. Frammenti di temi monkiani emergevano da una sorta di flusso di coscienza. Era un tentativo di esplorare il substrato del patrimonio afroamericano?
Esatto! A ragione parli di flusso di coscienza e anche Joyce è presente, sai? Il rischio è sempre quello della ri-produzione, e Walter Benjamin ci ha messi sull’avviso dichiarandoci «orfani d’Aura». Così quando prendi un repertorio innegabilmente connesso con un background specifico, con strumenti connotati in modo così forte come talking drum e percussioni etniche in genere, devi operare con grande prudenza e coraggio. Non sopporto il turismo culturale e musicale: la cartolina non mi appartiene. Con Giancarlo abbiamo individuato un nucleo generatore: il blues. Da questo abbiamo evitato la struttura formale che è sempre reiterata e quindi eludibile, l’impianto in Si bemolle ricorrente non è significativo. La musica di Monk si nasconde nei dettagli tematici che sottintendono degli aggregati armonici sempre logici perché derivati da costrutti intervallari espliciti. Tutto questo è stato «cucinato» con l’elettronica che è sempre memoria: in fondo il nastro è composto prima e si ripete non come sfondo ma come contesto. Ecco, in fondo è il contesto che mi interessa e che spiega anche le mie derive nel field recording e nel paesaggio sonoro (vedi «Mahler (in/a) Cage», Gruenrekorder, 2021). Abbiamo così voluto ri-leggere i frammenti tematici. In «Deconstructing Monk In Africa» non esiste improvvisazione se non tematica. Io non improvviso mai ed espongo semplicemente i temi permutandoli e modificandoli timbricamente, traducendoli infine tra balafon e talking drum all’interno di un contesto ipotetico molto ampio che unisce l’esperienza delle avanguardie, il jazz, il blues e un’idea di Africa. E così il cerchio si chiude.
Puoi parlarmi dell’esperienza di «Mahler (in/a) Cage»?
Il progetto «Mahler(in/a)Cage» si è andato definendo come un tentativo di estrarre dal paesaggio sonoro la memoria dei suoni di Gustav Mahler in relazione ad una partitura testuale come Sculptures Musicales di John Cage, dove l’idea di scultura sonora, espressa aforisticamente da Marcel Duchamp, acquista tutta la sua centralità all’interno di un paesaggio sonoro storicamente connotato come quello mahleriano. Per me si tratta della possibilità di ascoltare la memoria di un immaginario musicale all’interno di un paesaggio sonoro esistente. Così nell’estate del 2020, tra Santa Maria e Carbonin Vecchia a Dobbiaco, in Alta Val Pusteria, insieme al compianto Roberto Masotti abbiamo raggiunto la casetta di composizione di Gustav Mahler dall’altra parte della valle, costruendo un percorso d’ascolto di un paesaggio raccontato anche soggettivamente dentro il Canto della Terra, che proprio in quei luoghi Gustav Mahler aveva scritto negli ultimi anni della sua vita. Il lavoro di field recording mi permette sempre di intrecciare scrittura e ascolto stando al di fuori, o meglio al limite, di una pratica musicale che io considero oggi molto usurata, eccessivamente sovraesposta e ridotta spesso a puro consumo. Credo invece fortemente che l’atto dell’ascolto sia un processo di conoscenza e di consapevolezza intuitiva profondamente connessa con il nostro essere. Da una parte trovo il sonoro nella sua nudità, e questo mi permette il lavoro sul campo, mentre dall’altra ho a disposizione la musica nella sua complessità anche di linguaggio. Così posso scegliere dove stare ogni volta dal mio punto d’ascolto. In questo caso, solo dopo approfondite letture - in particolare partendo da un saggio di Adorno su Mahler - grazie alla collaborazione con l’ingegnere del suono Alessandro Camnasio ho concretizzato tutti i miei fantasmi sonori. Si è trattato per me di una fuga dal musicale e un approdo mentale necessario e purificatore verso l’ascolto.

Quali ritieni siano la funzione, l’efficacia, ma anche i limiti della didattica musicale, specie per quanto concerne il linguaggio jazzistico?
Il jazz è una scelta! In questo senso non è solo un linguaggio, ma un modo di vivere la musica dall’interno. In fondo, la stessa parola jazz non comprende ciò che la musica jazz, ammesso che esista, esprime. Dovremmo de-colonizzare la nostra mente ricercando un rapporto tra noi stessi e i suoni. Questo per me è il jazz in senso esteso, dove comprendo sia il gregoriano, Bach, Bartók, Cage, Scelsi o Stockhausen che Louis Armstrong, Charlie Parker, Thelonious Monk e Sun Ra, Fluxus, Bobby Hutcherson o Lipushiau, la prima suonatrice di tamburo della storia. Come vedi, non si tratta di definire stili e forme, ma di individuare il come di una pratica come quella dell’improvvisazione, anche se questa definizione non è mai esaustiva. Il libro di Derek Bailey Improvisation: Its Nature And Practice In Music ha di certo il grande merito di ampliare l’area geografica e mentale con una maggiore consapevolezza delle pratiche plurali del fare musica, dall’interno: dentro il suono. Tutto ciò che è fuori non mi interessa. Con fuori intendo tutto ciò che tocca la superficie ma non ha profondità: la musica come consumo culturale. Il jazz come forma stilizzata non è che l’ombra del jazz come scelta. La didattica musicale perde di efficacia quando, come scriveva Rudolf Steiner, «non è artistica» ma tende a conservare la superficie a discapito della profondità, della «possibilità di ascoltare un unico suono, la nota singola». Mi riferisco all’uso di patterns, sequenze o altro, che può essere utile per il controllo del proprio strumento ma purtroppo fallisce se sostituisce la presenza, l‘invenzione e l’errore come elemento fondamentale nella definizione di una propria voce, quello che Giancarlo Schiaffini chiama «il suono significante». In fondo nella musica improvvisata non si sbaglia mai! Questo purtroppo la didattica non lo può comprendere, mentre sarebbe più utile un pensiero pedagogico più ampio, complesso e aperto. In questo senso ritengo utile dedicare più ore allo studio, alla lettura e all’ascolto e meno alla tecnica intesa come addestramento. In fondo è la mente che guida le nostre mani e non il contrario, e l’ascolto è necessità di preparazione, anche spirituale. Questo è il vero esercizio per me. Mi riferisco ad una pedagogia rinnovata dove la didattica non è che la sua realizzazione pratica. Il jazz come linguaggio non può che inserirsi in questa dialettica tra pensiero pedagogico e didattica, non del tutto programmabile, di un assunto teorico complessivo. Inoltre, credo sia fondamentale partire dal presupposto che l’efficacia di una didattica musicale non possa che derivare dal contesto sociale, anche semplicemente considerando la condizione del musicista - di un musicista pensante - all’interno della società contemporanea.


 Sergio Armaroli
Sergio Armaroli